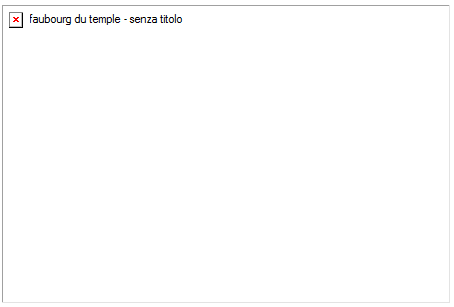tre sorelle senza mezzi toni
scritto giovedì 31 maggio 2007 alle 23:42
Non avevamo proprio bisogno di questa versione delle Tre sorelle di Čechov proposta dal Théâtre de la Colline dal 22 maggio al 23 giugno.
Non avere bisogno di uno spettacolo: definizione che va rigorosamente applicata a un certo tipo di teatro di cui questa lettura čechoviana di Stéphane Braunschweig è un esempio più che ludico. Nulla non va nello spettacolo: la recitazione è discreta in tutte le parti, la regia piuttosto equa, la durata possibile. Solo la scena, in fondo, è di livello più basso di quello medio, con qualche lapsus di cattivo gusto nelle sedie sfacciatamente IKEA, o nella idea un po’ trita delle inquadrature per punti di vista successivi a dividere i quadri di cui il testo di Čechov si compone in angolazioni di una stessa ricostruzione mentale della casa al centro delle vicende.
La stessa regista, scrive nel quaderno di sala «difficile de se départir de cette sensation que la pièce livre le portrait parfaitement daté d’une société depuis longtemps disparue, comme engloutie par le raz de marée de la modernité et rendue obsolète par l’accélération fulgurante de l’Histoire au XXe siècle» ammettendo così una sconfitta, quasi a giustificare un anacronismo.
Il testo è invece di folgorante attualità: la società rurale è in realtà una società provinciale, e quello che si consuma nella trama è lo scacco al positivismo, tema quanto mai urgente nelle società postmoderne e tecnocratiche di cui siamo parte.
Per fare Čechov bisogna essere russi, del resto: quello che manca qui è la tonalità media, propriamente slava, che maggiormente ha fatto il fascino dello scrittore. Epopea di smacchi e fallimenti, questo dramma si articola su scene, fotografie uscite dal tempo della narrazione, in personaggi trasparenti come meste rivelazioni di un futuro irrealizzabile.
La lenta e lasciva noia delle tre sorelle non ammette esplosioni se non nel breve spazio di un istante e trasforma la malinconia in un male sottile, un fumo, un nefasto magnetismo di cui non si conoscono né ragioni né intenti, sebbene prima o poi arrivi il colpo di pistola risolutivo.
L’esistenza si appiattisce come in una insensatezza sognante che qui è del tutto assente.
La versione che abbiamo visto nel teatro di pl. Gambetta si preoccupa delle motivazioni, delle intenzioni della narrazione, della consequenzialità degli avvenimenti. Ogni dettaglio ed angolo della camera oscura viene illuminato, privando il testo del suo enigma. A dare un colpo di spalla alla sottile magia čechoviana contribuisce anche la nuova traduzione di cui si è avvalsa la Braunschweig, uscita dal pugno di Françoise Morvan e André Markowicz per i quali è risolutiva la preoccupazione per un linguaggio contemporaneo il quale se proprio non pesca dall’argot francese ne riprende alcune frequenze.
Un’uscita dai mezzi toni che vorrebbe farla finita col giudizio di Stanislavskij, ma che poi se ne pente, introducendo qualche timido cinguettìo qua e là (ricordiamo che la regia del Teatro D’Arte era alle orecchie di Checov insopportabilmente colma di brusii e suoni ambientali) e non rendendo infine giustizia al lodevole impegno degli attori, fra cui spicca l’interessante evoluzione di Andrej, interpretato da Sharif Andoura.